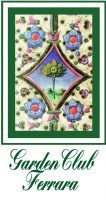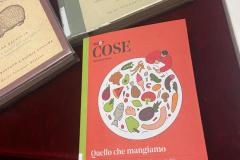“La botanica nel piatto. Le piante spontanee mangerecce” – Lisa Brancaleoni

Il Garden club Ferrara ha organizzato giovedì 20 marzo 2025 un interessante incontro con Lisa Brancaleoni, docente presso il Dipartimento dell’Ambiente e della Prevenzione dell’Università di Ferrara. Alla Biblioteca Ariostea si è tenuta infatti una conferenza dal titolo: “La botanica nel piatto. Le piante spontanee mangerecce”.
Lisa Brancaleoni ci ha parlato di come è cambiato il nostro modo di vedere le piante che oggi definiamo “erbacce” e che un tempo erano alla base della nostra cucina e della vita quotidiana. Abbiamo scoperto come riconoscere le piante da “mettere nel piatto”, quali possiamo mangiare in sicurezza, come si raccolgono e si cucinano senza alterarne le proprietà.
(Maria Teresa Sammarchi ha creato per l’occasione una composizione floreale dal titolo “Erborizzando in campagna”).
Nell’introduzione la presidente Paola Roncarati ha sottolineato l’importanza del rapporto tra Università e territorio e ha collegato, attraverso l’analisi di alcune opere di Giacomo Manzù, l’arte con lo studio e la rappresentazione delle erbe spontanee.
Di seguito il testo di Paola Roncarati
“Oggi, 20 marzo 2025, si celebra la giornata nazionale delle Università, la II edizione del progetto US, acronimo di Università Svelate, promossa dal CRUI, la Conferenza dei Rettori, in collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni italiani e il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca. Le Università intendono rimodulare il ruolo propulsivo che rivestono nello sviluppo del Paese e, sottolineatura oggi rilevante, nella promozione della coesione sociale. Nel 2025 si celebrano le città che hanno il privilegio di ospitare Università, come succede a Ferrara, perché si crea un valore aggiunto nell’interazione sinergica tra Università e territori. L’Università ridà nuovo vigore al suo essere un luogo di produzione e condivisione della conoscenza, diventando ‘piattaforma di innovazioni al servizio del Paese’. Oggi, a Ferrara, nella bella cornice del Salone d’onore di Palazzo Tassoni, sede del Dipartimento di Architettura, tanti progetti realizzati da diversi Dipartimenti con il contributo di Associazioni ferraresi venivano presentati ad un folto pubblico, anche di studenti, attorno al significativo obiettivo comune di esaltare il rapporto: Università-città. Si è celebrata l’apertura verso la società civile, verso le Associazioni che operano a favore del territorio, tra cui il Garden Club di Ferrara, che a tutt’oggi ha coltivato un rapporto di collaborazione con tre diversi Dipartimenti universitari.
Il primo progetto presentato è una sinergia di interazione sulla trasformazione di Casa Romei in Museo dei 5 sensi (Il Garden Club ha collaborato, dal dicembre del 2023 fino all’estate del 2024, per la realizzazione di un percorso museale sul senso dell’olfatto, mettendo in relazione il ‘Giardino delle Sibille’, felice intuizione del Direttore Andrea Sardo, da noi corredato di rose antiche e frutti, con le strepitose pitture murali delle Stanze delle Sibille e dei Profeti, di cui abbiamo raccontato al pubblico l’erbario dipinto nella fascia sotto il soffitto e la storia delle rose antiche). Risultato del progetto Universitario condiviso: 16.000 presenze in più rispetto al pubblico consueto di Casa Romei.
Oggi, qui nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea, si realizza una significativa coincidenza con l’evento nazionale: il Garden Club promuovere conoscenza con il supporto degli studi dell’Università, qui rappresentata dalla prof.ssa Lisa Brancaleoni, professoressa Associata presso il Dipartimento dell’Ambiente e della Prevenzione del nostro Ateneo. Oggi ci si soffermerà su una realtà botanica che può apparire meno attraente dell’illustrazione di un bellissimo giardino illuminato, specie in primavera, da una bella fioritura. Il giardino è una realtà recintata (gart -come hortus– significa luogo coltivato e protetto da muri o recinzioni, luogo dove gli esseri umani ricreano e modulano la natura a loro piacimento). Noi, oggi, usciamo culturalmente dai giardini, dai luoghi recintati e ci occupiamo di quel ‘tanto d’altro’ che è natura, una natura che può essere incolta, ricca di biodiversità, certamente un po’ arruffata, con piante che crescono in modo disordinato e vagabondo (erbacce!), ma che da millenni ci nutrono. Con le piante di questa natura libera abbiamo imparato ad alimentarci, a curarci, a creare farmaci utili per il benessere e la bellezza. Oggi privilegiamo il rapporto con l’alimentazione. Quindi … erbe preziose! A proposito di erbacce … vi sono artisti che hanno dato loro dignità d’arte.
Introduco l’argomento trattato dalla prof.ssa Brancaleoni da un altro punto di vista, quello artistico.
Mi riporto alla Seconda Guerra Mondiale: per l’esattezza, all’anno 1944.
Lo scultore Giacomo Manzù (1908-1991), bergamasco, famoso artista negli anni Quaranta, docente all’Accademia di Brera e all’Accademia di Belle Arti di Torino, autore di celebri portoni in bronzo per il Vaticano, della celebre serie di cardinali seduti e di busti di soggetti privati che diverranno ambitissimi, attraversa con sofferenza nel 1944 un periodo bellico molto cupo, era un cattolico, un pacifista, pativa di fronte alle efferatezze della guerra. Manzù si isola in una villa sul lago Maggiore, a Laveno, dei committenti De Angeli Frua (potente famiglia di industriali tessili). È nella villa per eseguire la scultura di un busto ritraente la moglie del proprietario, ma è oppresso da una profonda angoscia e avverte il bisogno di qualche attività che lo rigeneri, mentre passeggia solitario nel parco della villa e medita. In questo momento non gli basta il dialogo economico coi ricchi industriali che lo ospitano per lavoro, ha bisogno di qualcosa di autentico, di semplice, di intimistico e si dona il tempo per una serie di disegni botanici di erbe spontanee presenti nell’area verde della villa, vorrei dire nel giardino, ma possiamo supporre che in tempo di guerra il giardino non fosse curato. Quindi il lavoro di Manzù non si ferma all’interno della villa, ma esce nel parco poco curato e rivolge l’attenzione alle piante spontanee. Decide di disegnarle come fossero delle star, inchiostro su carta assorbente, esaltandone l’umiltà che lo scultore scrive di aver scelto per un bisogno morale, quasi a richiamare il motto di un’altra figura di spessore nata in quei luoghi, San Carlo Borromeo, che aveva scelto -come proprio emblema- la parola ‘Humilitas’, guardare in basso, per stare vicino alla terra. E Manzù sceglie di ritrarre piante umili, le vite semplici, le meno dominate dall’uomo. Che cos’è l’arte, si chiede? L’arte può catturare l’essenza, l’essenza delle vite.
Questi disegni, noti oggi come i TRENTA STUDI DI ERBE E FIORI. diventeranno un piccolo tesoro privato che egli non venderà, che terrà per sé come una lezione esistenziale. Questa raccolta di disegni del 1944 riemergerà solo nel 1985 (pochi anni prima della sua morte). Abbiamo riprodotto tre sole immagini:
Polygonum persicaria, una pianta annuale che nasce lungo i margini delle strade, con fiori riuniti in spighe terminali. Agricoltori e giardinieri la considerano molto infestante. Quindi è un’erbaccia. Manzù le dedica la prima pagina del suo diario. E scrive: La natura la ami se la conosci, e studiarla è difficile.
Campanula rapunculus o raponzolo. Anche questa pianta nasce negli incolti, se ne utilizzava la radice per scopi alimentari. Manzù è affascinato dai nodi fogliari e dalla scalarità della fioritura.
Foglie decussate (di pianta non classificata), con dettagli florali di difficile identificazione, ma lo scultore è affascinato dalla morfologia fogliare, in cui le foglie ad ogni nodo si sviluppano opposte. In basso a destra si disegnano dettagli in merito a questa morfologia. Ci fermiamo qui, ma le piante complessivamente sono 30.
Dall’arte orientale, qui a destra espongo su un leggio la riproduzione di una composizione dell’arte dell’IKEBANA, dal nome Hanamai (danza delle piante), che esibisce tre piante legate alla nostra alimentazione, in danzante relazione tra loro:
1) Typha latifolia; 2) Avena sativa; 3) Girasole
Non si richiede un passo indietro per apprezzare le piante spontanee mangerecce, dei campi o degli incolti. Ritengo che serva un passo avanti, una cultura più raffinata e originale per rivalutare le piante selvagge che con noi condividono il cammino sulla terra.”